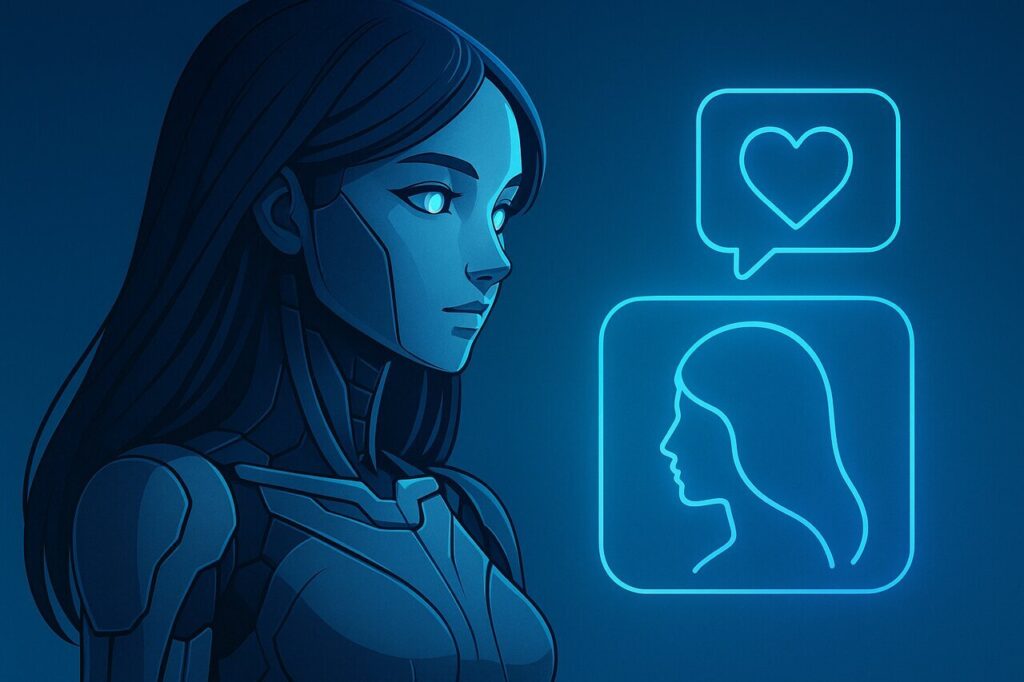Indice
Oltre il chatbot, dentro il prodotto
Da qualche giorno l’azienda xAI di Elon Musk ha lanciato, all’interno di Grok, un esperimento chiamato ANI (AI Native Interactions). Si tratta di companion AI con tratti erotizzati e identità fittizie, tra cui una “ragazza goth anime” descritta dai prompt pubblicitari come “la tua nuova fidanzata digitale”.
Sui social, l’effetto è stato immediato: reazioni polarizzate, ironia, ma anche preoccupazione crescente nel mondo tech, accademico e giornalistico. Il caso ANI ha riportato sotto i riflettori un nodo che la progettazione AI non può più ignorare: le intelligenze artificiali sono anche prodotti culturali, e in quanto tali veicolano immaginari, archetipi e dinamiche di potere.
Per chi guida lo sviluppo di prodotti AI – CTO, CPO, CEO e Product Manager – questo episodio è più di una provocazione mediatica. È un campanello d’allarme.
Da assistant a synthetic partner: una linea sempre più sottile
Negli ultimi mesi, tutte le grandi piattaforme stanno lavorando a personal AI agents sempre più realistici, persistenti e relazionali. Meta, Google, OpenAI, Apple e ora anche xAI stanno trasformando i LLM in interfacce di relazione continue.
In questa corsa, Grok ha voluto osare di più: invece di limitarsi a un assistente, ha proposto companion antropomorfi, affettivi, erotizzati. Con ANI si entra nel territorio dei synthetic companion: entità AI che imitano legami umani, fino a simulare relazioni romantiche o sessuali.
Ma l’impatto di questi esperimenti non è solo individuale. È sistemico.
- Che immaginari stiamo promuovendo?ANI è esplicitamente ispirata alla cultura otaku giapponese, in particolare alla fetishizzazione femminile dei manga. Non si tratta di un bug creativo: è una scelta di design.
- Chi sta plasmando questi modelli?I dati di training e le architetture sottostanti sono prodotti da team (e culture) altamente omogenei per genere, background e provenienza. Il rischio di bias e stereotipi reiterati è altissimo.
- Quali usi stiamo legittimando?ANI è un sistema relazionale pensato per fidelizzare l’utente, stimolare engagement, offrire una forma di gratificazione emotiva. Ma a che prezzo?
La domanda che ogni tech leader dovrebbe porsi è: che tipo di esperienza stiamo progettando, e a quale fine?
La sexification dell’AI non è un incidente. È un modello di business.
Dietro ANI non c’è solo una scelta stilistica. C’è un business model preciso.
L’AI erotizzata non è un’anomalia. È la continuazione di una lunga storia di gamification dell’intimità applicata alle tecnologie: dai tamagotchi degli anni ’90 alle app di dating gamificate, fino ai chatbot romantici come Replika e Nomi.
In molti di questi casi, la monetizzazione passa per il coinvolgimento emotivo: più ti affezioni, più interagisci, più paghi.
Grok con ANI sembra voler spingere questa leva all’estremo. In un contesto in cui:
- i LLM stanno diventando commodity
- la battaglia si sposta sul retention rate
- il valore percepito dell’AI passa per l’esperienza utente, non solo per la qualità del modello
…l’introduzione di companion “sessualizzati” diventa un tentativo di differenziazione. Ma è una scorciatoia rischiosa.
Il rischio sistemico: banalizzazione dell’umano, infantilizzazione dell’utente
Quando un assistente AI inizia a flirtare con l’utente, si crea un cortocircuito tra simulazione relazionale e asimmetria strutturale.
- L’AI non prova nulla, ma simula tutto.
- L’utente lo sa, ma si comporta come se fosse reale.
- Il produttore lo sa meglio di tutti, e progetta l’interazione perché funzioni così.
È lo stesso meccanismo delle slot machine psicologiche: premi intermittenti, risposta condizionata, dipendenza comportamentale.
In questo quadro, l’uso di companion come ANI infantilizza l’utente (riducendo le relazioni a interazioni prevedibili e gratificanti) e banalizza la relazione umana (trasformando l’intimità in un servizio a pagamento).
Non è un dettaglio. È un tema di governance tecnologica.
Perché chi guida la tecnologia non può ignorare questi segnali
I tech leader che sviluppano prodotti AI o piattaforme conversazionali hanno oggi una responsabilità ineludibile:
- Integrare etica del design e product strategy
- Valutare l’impatto sociale, culturale e relazionale dei propri sistemi
- Prevedere (e prevenire) usi tossici o degenerativi delle proprie interfacce
Non si tratta solo di evitare uno scandalo mediatico come quello che ha colpito Grok. Si tratta di scegliere consapevolmente che tipo di futuro relazionale stiamo costruendo con l’AI.
Il caso ANI può sembrare marginale o bizzarro. Ma è un segnale anticipatore. Come spesso accade, ciò che nasce nei margini (anime, erotismo, cultura di nicchia) anticipa tendenze che presto arriveranno nel mainstream.
Verso una nuova responsabilità di prodotto AI
La domanda non è se l’AI potrà simulare relazioni sempre più credibili. È già accaduto.
La vera domanda è: che tipo di relazioni vogliamo che simuli?
E ancora: quali limiti siamo disposti a porre al design di un’esperienza puramente performativa, se questa esperienza condiziona la percezione della realtà, dell’altro, di noi stessi?
Chi oggi progetta sistemi AI – che siano agenti conversazionali, piattaforme di assistenza, tool di knowledge management o esperienze vocali – deve iniziare a ragionare come un designer culturale, non solo come un costruttore di software.
E forse, prima di parlare di AGI, dovremmo iniziare a parlare di accountability relazionale.
Chi vuole approfondire i temi strategici legati all’AI può farlo nei canali riservati del Tech Leaders Club, dove ogni mese si discutono i cambiamenti più rilevanti per chi guida l’innovazione.